Ugo Gervasoni – Le voci dei maestri
Mario Vargas Llosa, I
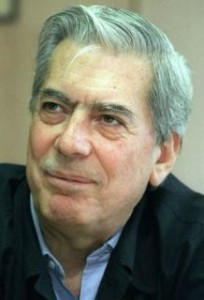
(Arequipa, Perù, 1936)
Mario Vargas Llosa è un prolifico narratore dallo spiccato talento affabulatorio: esordì giovane con un romanzo di notevole spessore drammatico, La ciudad y los perros (La città e i cani), in cui non erano assenti quelle inquietanti atmosfere che un lettore europeo poteva avere conosciuto nelle pagine crude de I turbamenti del giovane Törless,la prima significativa opera letteraria di Robert Musil, ambientata in un collegio austriaco dai sadici rituali. Insieme con Gabriel García Márquez, l’autore dell’indimenticabile Cien años de soledad, Mario Vargas Llosa rappresenta l’eccellenza della letteratura sudamericana contemporanea: curiosamente, dopo una iniziale mutua simpatia, i due scrittori si raffreddarono l’uno verso l’altro, anche a causa di divergenze politiche; l’ideologia, anzi, la fede comunista di García Márquez non si armonizzava con le posizioni ispirate alla grande tradizione liberale abbracciate da Vargas Llosa.
Oltre ai numerosi romanzi che gli valsero il Premio Nobel nel 2010, Vargas Llosa è significativo e importante in qualità di saggista e di critico sociale e culturale: la passione e l’acutezza delle sue interpretazioni di ciò che accade nel mondo delle idee e dei comportamenti del nostro tempo non possono essere trascurate da chiunque abbia a cuore i temi che egli tratta. Il libro che ho recentemente terminato di leggere e annotare, e che vivamente raccomando a tutti coloro che non considerano irrilevanti le gioie che dona un pensiero vivace e provocatorio, si intitola La civilazación del espectáculo (La civiltà dello spettacolo, in italiano), pubblicato nel 2012: è una vibrante, intensa disamina del significato che il termine “cultura” ha avuto per secoli nella storia dell’Occidente, e dei cambiamenti o slittamenti semantici che ha subito negli ultimi decenni.
Il libro prende inizio dalle definizioni classiche del termine “cultura”, citando autori eccellenti come il poeta T. S. Eliot, il prestigioso docente delle università di Ginevra e di Oxford e di Harvard George Steiner, e via via altri nomi di studiosi più recenti, sostenitori di posizioni diversificate, talvolta sconcertanti. La cultura, nel suo senso tradizionale, non era soltanto una serie di attività che si nutrivano di determinati contenuti, era, soprattutto, uno stile di vita che aspirava al raffinamento della persona: la “forma” non era una semplice veste del “contenuto”, era la cura amorevole del messaggio che si intendeva comunicare, rappresentava l’ordine della mente che aveva per fine il bello e il buono. Era attività totale, imprescindibilmente legata ad una attitudine etica, spesso religiosa, nei confronti della vita, nutrita di rispetto, di reverenza, di gratitudine. L’impegno dell’uomo di cultura era di creare un’opera che trascendesse il tempo, intesa ad offrire le proprie intuizioni non solo ai contemporanei, ma ai posteri, che potevano essere appena intravisti nella nebbia del futuro. Mi sono rimaste impresse, a questo proposito, le parole con cui il filosofo Arthur Schopenhauer introduceva la seconda edizione del suo capolavoro Il mondo come volontà e rappresentazione, nelle quali il suo essenziale pessimismo si redime grazie alla fede nella imperitura bontà dello spirito: “Non ai contemporanei (Nicht den Zeitgenossen), non ai connazionali: all’umanità consegno la mia opera ormai compiuta, nella sicurezza che non sarà per essa senza valore, quand’anche ciò dovesse, come il destino del bene in ogni forma comporta, essere riconosciuto soltanto tardi. Giacché solo per essa, non per la generazione che passa in fretta (das vorübereilende Geschlecht), presa nella sua illusione del momento, può essere avvenuto che la mia mente, quasi contro la mia volontà, abbia atteso ininterrottamente al suo lavoro per una lunga vita. (trad. it. di Sossio Giametta)
Ciò che è mutato nella nostra civiltà dello spettacolo, votata al facile consumo e al divertimento coatto, è proprio questo: se i prodotti della cultura tradizionale ambivano alla durata oltre i limiti temporali della generazione che li creava, i prodotti di questa nostra, rileva Vargas Llosa, “sono fabbricati per essere consumati all’istante e scomparire, come i biscotti e il popcorn. Tostoj, Thomas Mann, e ancora Joyce e Faukner scrivevano libri che intendevano sconfiggere la morte (derrotar a la muerte), sopravvivere ai loro autori, continuare ad attirare e ammaliare i lettori nelle età future. Le telenovelas brasiliane e i film di Bollywood, al pari dei concerti di Shakira, non intendono durare più del tempo della rappresentazione, e poi scomparire per lasciare spazio ad altri prodotti ugualmente popolari ed effimeri. La cultura è divertimento, e ciò che non è divertente non è cultura.” La passione dominante del nostro tempo è di evadere ad ogni costo dal mondo della noia che la impressionante ed inarrestabile rivoluzione tecnologica ha accentuato; le conseguenze impreviste sono state “la banalizzazione della cultura, la generalizzazione della frivolezza e, nel campo della informazione, la proliferazione del giornalismo irresponsabile che vive di scandali e di pettegolezzi.”
Viviamo, ahimè, nel regno della quantità, la qualità è un lusso di cui si fa volentieri a meno: non viene premiato ciò che è eccellente rispetto ai criteri della compiutezza formale e della originalità di pensiero, ma ciò che vende bene e subito, perché, di fatto, solletica il gusto depravato del maggior numero di consumatori. Si scade facilmente nella sfera-immondizia di ciò che è morboso e volgare, ovvero i costumi sessuali privati dei personaggi che godono della celebrità, che naturalmente non sono artisti o intellettuali, ma calciatori (che, si sa, non si guadagnano la loro lauta vita usando il cervello, ma principalmente i piedi) e attrici (che fanno abbondante ricorso ad altre parti del loro corpo piuttosto lontane dalla testa). In quella che è stata definita cultura-mondo, i programmi televisivi di Oprah Winfrey hanno preso il posto degli elzeviri dei critici sociali di un tempo, che dettavano gusti e ampliavano orizzonti. Cultura era cura della propria crescita intellettuale; è ora intesa, sempre più, come l’insieme degli aspetti di una comunità: cultura è la sua lingua, cultura sono le sue credenze usi e costumi, cultura sono i suoi vestiti e le sue tecniche, tutto ciò che, in una società, si pratica e si rispetta o si proibisce. Tutto allora si uniforma, un concerto di Beethoven vale tanto quanto una serata dei Rolling Stones, la filosofia di Immanuel Kant quanto uno spettacolo del Cirque du Soleil. La cultura è divenuta chiacchiera che sfocia nell’autocompiacimento e nello stereotipo. (continua)

(L’autore durante una occasione pubblica)
