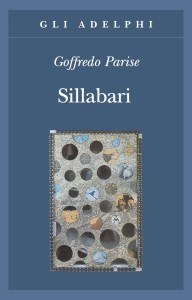Ugo Gervasoni – Le voci dei maestri
Goffredo Parise

(1929 – 1986)
Il prete bello è un romanzo che Goffredo Parise scrisse nel corso dell’anno 1953, dopo che si era trasferito a Milano per lavorare presso la casa editrice Garzanti. Secondo quanto lo scrittore annotò, voleva allora raccontare una storia che lo divertisse e lo commuovesse allo stesso tempo, “tanto da cacciare il freddo e la solitudine.” Storia apparentemente modesta, che si svolge in un caseggiato popolare di Vicenza, città natale di Parise, nel 1940, il romanzo è in realtà, come tante opere d’arte che, concentrandosi con compiutezza e amore sul particolare giungono ad illustrare e a commentare l’universale, una felice ricreazione di quella Italia che stava per entrare nella seconda guerra mondiale, impreparata e fiera e patetica. Si presenta la vita ovattata e crepuscolare e gelosa di signorine attempate e ansiose, i cui appetiti di amore non vogliono ancora essere spenti; di impiegati statali la cui consunta apparenza trasuda perbenismo e grettezza e comica volgarità; di anziani affetti da inarrestabili tumori o da clamorose flatulenze; di ragazzi perennemente in moto tra cacce e inganni e complotti per soddisfare la fame dello stomaco e quella del sesso, sognando le gesta di Coppi e di Bartali; di ragazze provocanti che o sono vittime della clausura casalinga imposta dal genitore meridionale, o vivono sole, come l’affascinante Fedora, che con naturalezza scandalosa gode della propria straripante sensualità, né si perita di celarla altrui. Tra queste figure irrompe il protagonista, don Gastone, il prete bello, e i sospiri che vengono esalati nel caseggiato per compiacerlo scorrono per gli stretti corridoi, echeggiano nei bui anfratti, salgono e scendono le scale pericolanti. Don Gastone sfrutta, senza parere, il proprio fascino per il bene della Chiesa, e fa nascere pie associazioni che si dotano di gagliardetto e di uniformi, fa acquistare addobbi, organizza addirittura il ricevimento del Duce, in visita attesissima alla città. Proprio in questa occasione il comico, invero degno delle pagine di Giovanni Boccaccio, esplode, letteralmente, nel romanzo, allorché, pochi minuti prima dell’arrivo di Sua Eccellenza, il Cavalier Esposito (è lui il carceriere delle cinque figlie, in nome dell’onore e della virtù piccolo-borghesi; ed è lui lo spasimante frustrato di Fedora : “Lasseme vede’ ‘na zinna toia, Fedora bella, lassamélla vede’!”) è vittima del crollo del gabinetto aggettante che aveva sequestrato al caseggiato per solo suo uso personale, e rimane sospeso in aria con i calzoni calati, mentre franano i calcinacci. Le due personificazioni del fascino di questo romanzo non possono che incontrarsi e sentire mutua attrazione: accadrà ciò che il lettore curioso scoprirà se si lascerà coinvolgere dal ritmo e dall’intreccio del libro. Parise alterna tanti registri narrativi, dal naturalistico al grottesco al commovente al comico al drammatico al tragico, senza perdere intensità né incappare in stonature. Magnifico è il paragrafo finale che è insieme conclusione della storia e apertura maliosa sull’indefinito, volo di parole leggero ed elegiaco:
“Mamma, mamma mia” disse; Cena domandava mamma e non poteva avere neppure quella; certo la mamma che lui chiamava non era quella che lui aveva conosciuto, non la sua, ma un’altra. Piangendo guardava fuori dalle vetrate con i suoi occhi innocenti dove non c’era furto, né coltello che aveva ucciso, né ladrocinio, né incoscienza, né criminalità. Guardava quel rosa granatina, che era ormai una striscia, perdersi in un lungo filo d’orizzonte che comprendeva i campi, il canale con le anguille e le carpe, il cimitero degli ebrei dove sotto una vecchia lapide abbandonata c’era stato uno dei nostri nascondigli. Guardava tutto questo e nei suoi occhi a un certo momento apparve una Legnano da corsa nuova fiammante; guardava e pregava anche per avere una vita migliore in questo mondo e in mezzo agli uomini più grandi e più fortunati di lui e proprio mentre stava passando in rassegna tutte queste cose sulla sua nuova bicicletta, questa si alzò, e Cena, rifiuto di riformatorio, ladro e miserabile a dodici anni, abbandonò con essa le strade di questa terra.
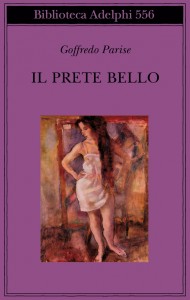
Tra il 1971 e il 1972 e, poi, tra 1973 e il 1980, apparvero sul “Corriere della Sera” i racconti in seguito raccolti nel volume Sillabari, pubblicato nel 1984. L’intento di Parise era di comporre una serie di brevi storie seguendo l’ordine alfabetico, partendo dalla A e terminando quindi con la Z. Come chiarì lo scrittore, “sono poesie in prosa. Ma alla lettera S, nonostante i programmi, la poesia mi ha abbandonato. E a questa lettera ho dovuto fermarmi. La poesia va e viene, vive e muore quando vuole lei, non quando vogliamo noi e non ha discendenti. Mi dispiace ma è così. Un poco come la vita, soprattutto come l’amore.” Da Amore Bacio Caccia, continuando con Dolcezza Estate Famiglia, proseguendo con Gioventù Hotel Ingenuità, e ancora Lavoro Madre Noia Odio Paternità, si giunge a Ricordo Solitudine. Ed altri titoli che qui non riporto. Momenti di vita molto semplice, vissuta da personaggi ordinari, ora adulti ora bambini, uomini e donne, tristi o annoiati o in cerca della felicità. Si possono leggere in sequenza, o scegliere invece quelli il cui titolo promette di soddisfare un bisogno o un sentimento momentanei: l’insieme non ne risente, la preziosità della trama narrativa brilla dello stesso splendore, il ricamo stilistico non si sciupa. Alberto Arbasino, che a Goffredo Parise dedica, da amico, toccanti pagine in Ritratti italiani, così si è espresso a proposito di questo volume: “E la scrittura, soprattutto. La ‘griffe’ soffice e tagliente della ferma e delicata prosa dei Sillabari, trasferita dall’invenzione alla testimonianza, alle selezioni dell’osservazione, alla solidarietà col vissuto, dilettante e chic.”
James Joyce pubblicò, nel 1914, Gente di Dublino, quindici racconti che intendevano costituire un capitolo della storia morale dell’Irlanda, presentando personaggi e situazioni talmente individuali da risultare emblematici della condizione umana generale. Soprattutto, Joyce voleva che ogni racconto registrasse e svelasse un momento epifanico, uno squarcio rivelatore della essenza della vita, colto in un gesto banale, o in un giro di parole, o in uno sguardo e in un silenzio. Come i Re Magi videro la divinità nella nuda presenza di un Bambino, Joyce coglieva la verità di un momento storico che cadeva sotto il suo attento sguardo, lo portava alla luce e lo raccontava. I poemi in prosa di Sillabari sono altrettante moderne epifanie, che fanno del quotidiano una sorgente imprevista di sorprese e di stupore e di mistero. I due paragrafi iniziali del racconto Italia ne sono un buon esempio:
Un giorno di settembre sotto un’aria che sapeva di mucche e di vino due italiani di nome Maria e Giovanni si sposarono in una chiesa romanica già piena di aria fredda con pezzi di affreschi alti sui muri di mattoni: raffiguravano il poeta Dante Alighieri, piccolissimo, inginocchiato davanti a un papa enorme e molto scrostato, seduto sul trono. C’era anche un cagnolino nero. La chiesa appariva in quegli anni lontani solitaria nel mezzo di una pianura di granoturco e aveva accanto uno stagno con anatre e oche grandi e piccole.
Entrambi erano giovani, Maria aveva 18 anni, Giovanni 25, si conoscevano fin da ragazzi, anche le famiglie si conoscevano e avevano una discreta fiducia fra loro. Il padre di Giovanni disse al figlio, subito dopo le nozze: “Non fidarti di nessuno. Tutti dicono che l’onore non conta niente e invece conta più della vita. Senza onore nessuno ti rispetta.” Strano discorso il giorno delle nozze ma Giovanni capì benissimo anche senza capirlo il discorso del padre, che tutti credevano un bonaccione.