Ugo Gervasoni – Le voci dei maestri
James Joyce, I

(1882 – 1941)
Di James Augustine Joyce, come di molti autori della letteratura mondiale di questo e di altri secoli, è più noto il nome che le opere. Questa figura di artista esule, segnato dall’anelito alla ribellione, sbocciato su un terreno cattolico coltivato con cura dal magistero gesuitico, rischia ormai il destino degli scrittori che hanno operato una rivoluzione nella sfera della loro arte: essi divengono figure di culto e di studio nei cenacoli dall’aria artificiosa delle università, oggetto di dissertazioni formali e strutturali e semiologiche e narratologiche, che hanno con la sua opera la stessa parentela che sussiste tra la vita e la morte, tra l’acqua che scorre e che zampilla e che rinfresca e la pozza immota e melmosa. Allora rischia di accadere davvero ciò che lo scrittore americano Henry Miller, il libertario autore di Tropico del cancro, rimproverava con esuberanza critica al genio irlandese, ma che è tanto più vero per i suoi anemici chiosatori: “Il suo linguaggio è una feroce masturbazione compiuta in quattordici lingue. E’ una danza da derviscio eseguita alla periferia della significazione; un orgasmo non del sangue e del seme, ma della scoria morta proveniente dall’arso cratere della mente. La Rivoluzione della Parola, che la sua opera sembra avere ispirato nei discepoli, è il logico risultato di codesta sterile danza della morte.” Chi si è avvicinato alle pagine di Joyce con l’animo disposto all’ascolto della sua magia verbale, sa che non è così: in tanti passi di Joyce si rinviene il compiuto, smagliante risultato del travaglio di una sensibilità artistica che ha cercato e trovato la bellezza nei momenti della vita che parevano i più ordinari e i più lontani dalla dimensione estetica: un frammento di conversazione tra due sconosciuti colto per strada, una ragazza che titubante alza la gonna per bagnarsi le gambe nelle onde del mare, un anziano sacerdote che si piega ad attizzare il fuoco nel camino della sua stanza. Joyce sa fare uso dello sguardo che rinnova l’esperienza delle cose.
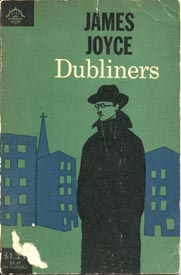
Così come i magi seppero vedere nel bambino neonato di Nazareth la divinità di cui erano assetati e per cui avevano affrontato il lunghissimo viaggio, Joyce trapassa la spessa coltre che ingromma e distorce lo spettacolo del mondo, rimuovendo la quale la scena quotidiana diventa epifania, cioè, etimologicamente, manifestazione dell’essenza, luce che esulta, splendore senza fine. Abbondano gli esempi nella raccolta di novelle intitolata Gente di Dublino: nel racconto Arabia, ad esempio, la ragazza che ha fatto provare le prime punture dell’amore al tormentato fanciullo protagonista è improvvisamente avvolta da una calda trasfigurante aureola, mentre posa assorta sul portico della sua casa, oggetto di vago desiderio e ingenua adorazione:
La luce del lampione di fronte colpiva la bianca curva del collo e illuminava i capelli raccolti sulla nuca, la mano posta sulla ringhiera. Cadendo di lato sul vestito, colpiva anche l’orlo bianco della sottana, che la posa trascurata lasciava intravedere.
Il pittore olandese Jan Vermeer seppe ricreare con la stessa fascinosa intensità la morbidezza della luce che definisce e insieme trasumana i soggetti dei suoi quadri. Tutti i quindici racconti di Gente di Dublino ruotano intorno alle immagini o ai momenti fuori del tempo che soli possono rischiarare il magma del flusso esistenziale. Joyce sa cogliere, però, anche il lato meno gioioso della manifestazione epifanica, quando la luce diventa, come nell’Inferno dove è precipitato Lucifero-Satana di John Milton, tenebra visibile: è presentata allora l’evidenza dello squallore di tanta parte della vita moderna. Sempre in Arabia, il fanciullo protagonista che con ansia ha atteso il momento magico di visitare il bazar per potere acquistare un oggetto da portare in dono alla fanciulla che gli ha tolto il riposo, giunge troppo tardi all’ingresso del grande edificio che trasuda aure orientali, è ormai quasi l’ora della chiusura, più nessun visitatore si aggira tra le bancarelle, grava sulle cose e sulle poche persone l’aria stagnante della fine dell’evento, quando si smontano supporti e strutture. Sperduto, frustrato, il giovinetto si avvicina all’unico posto ancora poveramente frequentato, sentendosi escluso e ridicolo, e conosce tutta l’amarezza dei sogni infranti:
Udii che una voce urlava da una estremità della galleria che la luce era spenta. Lo spazio in alto di quel vasto ingresso fu completamente in ombra. Alzando gli occhi in quella tenebra mi vidi come una creatura spinta e derisa dalla vanità, e i miei occhi sentirono il bruciore dell’angoscia e della rabbia.
I racconti di Gente di Dublino sono il frutto artistico della scoperta che James Joyce fece in giovane età: la città moderna è il luogo della paralisi, opprime e offende gli uomini e le donne, impedendo loro di crescere e di coltivare i propri talenti. Come lo scrittore specificò in una lettera, “chiamo la mia serie di racconti Gente di Dublino, per mettere a nudo l’anima di quella emiplegia o paralisi che molti considerano una città.” Anche Eveline, la protagonista dell’omonimo racconto, non sa cogliere l’occasione di liberarsi dalla penosa serie dei suoi giorni governati dalla tirannia del padre e da quella del lavoro ai Grandi Magazzini e, come chi soffre di paralisi motoria, si ritrova incapace di abbandonare la stasi della città e della sua vita per abbracciare l’avventura che le offre Frank, il giovane che si è innamorato di lei e la vuole sposare per offrirle la fortuna che ha trovato in un altro paese, a Buenos Aires. La paralisi spirituale è altrettanto impietosa che quella fisica.
L’epifania è anche il momento della rivelazione suprema della bellezza, uno dei cui aspetti è il fascino spesso struggente della prosa di Joyce: si veda, come esempio senza pari, il finale del racconto I morti, l’ultimo gioiello della raccolta, nel momento in cui il lento cadere della neve, reso nei morbidi suoni delle consonanti che si susseguono fruscianti e nella suggestiva ripetizione che, a brevissima distanza, genialmente si presenta rovesciata nel proprio ordine verbale (cadere lenta…lenta cadere), si confonde con il sonno in cui silenziosamente affonda il protagonista. Come la rivelazione del bello accada lo spiega Joyce steso per bocca di Stephen Dedalus, il personaggio che è l’alter ego dello scrittore. Tre cose sono necessarie perché la bellezza si manifesti, argomenta Stephen citando il filosofo medievale Tommaso d’Aquino: integritas, consonantia, claritas, ovvero interezza, armonia, splendore. La mente è attratta dapprima dall’oggetto singolo delineato nello spazio, distaccato da tutto ciò che lo circonda; poi è colpita dalla natura dei suoi rapporti interni, che formano linee e volumi di innegabile armonia; infine si placa nella contemplazione della sua essenza, che rifulge come luce e produce l’incanto del cuore: è il momento piacere estetico e intellettuale. Chi comprende questo processo percettivo, vivrà più intensamente le occasioni in cui la bellezza lo visita, sarà grato che gli siano state offerte, sentirà maggiore rispetto per cose e persone. Una sensibilità potenziata e purificata segna, come più volte è capitato di segnalare, il legame tra la sfera estetica e quella etica e può ricordarci, se così siamo disposti, i penitenti dell’ultima balza del Purgatorio dantesco, che affinano le anime nel fuoco per renderle pure e disposte a salire alle stelle.

