Ugo Gervasoni – Le voci dei maestri
Herman Melville, I

(1819 – 1891)
Herman Melville pubblicò Bartleby lo scrivano: una storia di Wall Street, in forma anonima, nei numeri di novembre e dicembre 1853 di Putnam’s Monthly Magazine, dopo avere firmato un contratto di cinque dollari per pagina, – il compenso più alto che uno scrittore potesse allora conseguire per collaborazioni a riviste.
La prima cosa che colpisce in questa vicenda è l’anonimato: perché l’autore si celò dietro la sua opera, rinunciò cioè al privilegio della rivendicazione del testo e, come avrebbe avuto diritto di sperare, della gloria? La risposta non può essere cercata soltanto rovistando tra le vicissitudini biografiche dell’allora trentaquattrenne scrittore che, dopo avere conosciuto un inebriante successo all’inizio della sua carriera, al tempo della pubblicazione di Taipi, la storia del suo soggiorno tra i cannibali del Pacifico, soffrì per molti anni di un oscuramento della sua popolarità, inversamente proporzionale all’approfondimento della sua visione e alla qualità della sua opera.
Un autore caduto in discredito non ottiene per caso le migliori condizioni di mercato da un editore di riviste letterarie che lo sappia, o lo sospetti, in fase involutiva. L’accoglienza di Moby-Dick, uno dei capolavori della letteratura mondiale, uscito nel 1850 negli Stati Uniti e in Inghilterra, era stata deludente, nonostante l’immenso sforzo compositivo dello scrittore, che nel libro riversò i temi più intensi della sua speculazione, rivestendoli delle atmosfere esotiche della caccia ossessiva al mostro marino più grande e più pericoloso, Quasi non si può parlare di vendite per il suo libro successivo, Pierre, o le ambiguità (1851), il settimo ambizioso romanzo che Melville diede alla luce nello spazio di sette anni: poco più di duecento copie vendute in dieci mesi. L’autore non si lasciò cadere preda della sfiducia, cercò di superare gli stadi di scoramento e, pur sofferente a causa di “severi dolori reumatici” (secondo la testimonianza della moglie), continuò a produrre letteratura grazie ad uno sforzo creativo impressionante, che non ha eguali tra i suoi contemporanei. Occasionalmente scelse eccentrici pseudonimi, come nel caso della pubblicazione degli splendidi bozzetti delle Encantadas, le isole incantate meglio conosciute come Galapagos (visitate anche dal giovane Charles Darwin nel 1839, durante la lunga crociera a bordo del Beagle), che apparvero nel 1854 a nome di Salvator R. Tarnmoor. Di regola, però, Melville preferiva presentarsi al pubblico senza maschere, anche nel caso di opere in stridente contrasto con i tempi, come accadde quando terminò il suo lunghissimo poema Clarel, un pellegrinaggio in Terra Santa, che apparve a proprie spese nel 1876. Solo nel 1855, mentre stava lavorando a L’uomo di fiducia, ultima pubblicazione in prosa della sua vita (1857), che denunciava l’avidità e l’egoismo e l’ipocrisia “di tutti e di nessuno” con una forza satirica degna di Jonathan Swift, lasciò uscire anonimamente il racconto La torre campanaria, e in seguito la sua geniale ricreazione della inquietante storia del capitano di mare Benito Cereno e del suo luciferino servo nero Babo, sempre nella rivista letteraria Putnam’s.
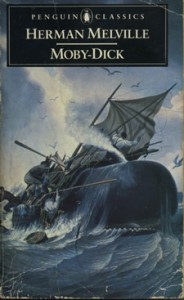
Ma l’anonimato di Bartleby acquista una valenza particolare che gli deriva molto probabilmente dal contenuto stesso della storia: il racconto poté apparire senza l’accompagnamento del nome dell’autore, perché il suo messaggio artistico fu tale agli occhi del sofferente Melville che il suo nome in testa alla narrazione gli sembrò, ad un certo punto, superfluo, forse addirittura improprio. Come un raffinato intenditore che si lascia affascinare dalla maliosa compiutezza e insieme dal prezioso dettaglio rivelatore dell’opera, lo scrittore, possiamo immaginare, accarezzò con lo sguardo questa sua creatura così strana e così amata, così delicata e insofferente di frettolose manipolazioni e interpretazioni offensive, e la pubblicò senza curare di firmarsi, contento di sapersi, comunque, dietro e dentro di essa, nella veste del principio formatore senza il quale essa non avrebbe mai potuto comunicare le sue magie. La seconda sensazione che, continuiamo ad immaginare, assalì lo scrittore e forse lo sorprese, è conseguente anche se inaudita: poiché la parabola dello scrivano non lo lasciò indifferente, Melville sentì – insieme ed in contrasto con la innegabile paternità artistica – che ciò che era stato spinto a creare non era più soltanto rivendicabile come lavoro suo proprio, ma aveva acquisito una natura autonoma, e ripeteva il suo mormorante, insolubile enigma secondo toni che più non potevano definirsi umani.
Lo scrittore americano improvvisamente sperimentò (non sappiamo se per la prima volta, ma ora con una chiarezza inusitata) la “capacità negativa” di cui parlò il poeta inglese John Keats in una delle sue lettere, ossia quel momento magico ed elusivo che solo il vero artista può attingere, quando d’improvviso si rende conto di sapere, senza neppure averlo pensato, che l’accettazione dell’assenza di spiegazioni definitorie nella vita deve essere totale, che un uomo può vivere nelle incertezze, nei misteri, nei dubbi, senza l’appoggio disperatamente voluto di fatti e ragioni. Il poeta, secondo Keats, non è legato alla propria identità e possiede la capacità di sfuggire o negare la propria individualità, aprendosi senza pregiudizi alla complessa, irridente, irrisolta realtà che lo circonda e lo ispira. Il corollario che Herman Melville aggiunse a questa esperienza trasumanante fu che l’artista poteva, almeno per una volta, comportarsi con la sua opera con il magnanimo distacco di colui che di cuore dona, piuttosto che con la bramosa avidità dell’avaro; egli poté ritirarsi contento da essa, lasciandola scintillare nella sua propria virginale luce, sentendosi contemporaneamente coinvolto in essa e sciolto da ogni vincolo nei suoi riguardi, in quella condizione oltre le passioni e gli aggettivi che le accompagnano, che fa presentire e talvolta precede l’inatteso, gratuito emergere di una rivelazione che non è stata coscientemente cercata.
Dopo avere viaggiato per i vasti oceani della terra ed essersi tuffato nei loro abissi in compagnia delle balene e dei capodogli, Melville scrisse un racconto che si svolge tra le strade e gli edifici di una città, che è insieme un enigma in prosa e il distillato di quanto lui stesso scorse tra le nebbie del mondo dell’apparenza, ponendo addirittura in essere la più difficile e la più sconcertante delle pratiche iniziatiche, cioè lo sforzo di liberarsi del proprio io limitato e fallace. Il momento della chiaroveggenza sorprese Melville solo dopo che ebbe finito il suo racconto poiché, come insegna ogni vera esperienza estatica, esso non può mai essere programmato pur essendo il frutto di una lunga e severa disciplina: la passione dello scrivere – lo scrittore preso dall’incanto della parola ancora innegabilmente sua – lasciò il posto alla separazione dell’autore dalla creatura finora accudita con tanto assiduo amore, – lo scrittore sorpreso da ciò che lo sguardo da lontano gli mostrò come già non più suo.
Il creatore imparò ad apprendere, per primo, i messaggi della sua opera.

Gregory Peck nel ruolo del Capitano Achab, nella versione filmica di Moby-Dick del 1956.
