Ugo Gervasoni – Le voci dei maestri
Stefano D’Arrigo

(1919 – 1992)
Per vastità di disegno e ricchezza linguistica, non soltanto per la straordinaria mole di quasi 1.300 pagine, Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo, non ha eguali nella letteratura italiana del secolo XX. La monumentalità stessa dell’opera consente paragoni soltanto con libri quali Ulisse di James Joyce, La montagna incantata di Thomas Mann, Il dottor Zivago di Boris Pasternak. Ma al di là dell’aspetto quantitativo, che pure è rilevante, tutte queste opere, mi pare, stanno insieme in un gruppo “venerando e insieme terribile” perché divennero, nella vita dei loro autori, la giustificazione e la soluzione della loro vicenda artistica ed esistenziale, l’asse intorno al quale si costruì la loro comprensione del mondo, la concentrata e feconda volontà di dare ad esso un senso e una forma. Opere totali come le Summae di Tommaso d’Aquino, con una fondamentale differenza, però: se il padre domenicano, dottore angelico, sistemava e chiudeva tutta la vita nella possente struttura razionale e teologica che il suo pensiero poteva concepire, queste opere del XX secolo aprono piuttosto nuove modalità alla percezione e alla comprensione del mondo. La parola fine, in questi romanzi, è una variante dell’invito a ricominciare da capo la lettura dell’opera e del mondo; addirittura in Finnegans Wake di James Joyce, l’ultima parola del possente, inarrestabile fiume narrativo è l’articolo determinativo cui deve necessariamente seguire il sostantivo che apre la narrazione all’inizio del libro, secondo il ritmo ciclico della storia umana che fu teorizzato da Gianbattista Vico.
Ad Horcynus Orca Stefano D’Arrigo lavorò molti anni, riascoltando e reinterpretando, mentre lo costruiva, i miti che stanno al centro e contemporaneamente al di sopra dello scorrere dei secoli. Li sentiva, essi soli, in armonia con la sua voce che cantava il ritorno dell’eroe, le prove della vita, i ritmi del mare, la morte. ‘Ndrja Cambrìa, nocchiero semplice della fu regia Marina, che ritorna a Cariddi dopo lo sfacelo dell’autunno 1943, è il nuovo Odisseo di cui Omero raccontò il peregrinare difficile e lungo e amaro. In modo più intimo, più sofferto e più struggente che non accada con Leopold Bloom, il viandante di Joyce che incontriamo per le strade di Dublino, i passi di guerriero di ‘Ndrja Cambrìa ripetono le movenze dell’uomo dal multiforme ingegno, che tra pericoli e seduzioni umani e più che umani costantemente cercò di giocare il suo ruolo di viandante curioso delle cose del mondo, e costantemente interrogò il suo cuore, senza stancarsi di distillare sapienza da sofferenza. Joyce amava il comico, con D’Arrigo si respira l’aura epica, nella quale si svolgono i miti, le leggende, le storie degli dei e degli eroi: sono le sirene maliose, il vecchio spiaggiatore, il tedesco che deve morire, le fere, la barcabara di don Luigi, la sorprendente Cosciaperte invaiolata in attesa. Come i veri maestri d’arte, D’Arrigo conia il suo linguaggio, grazie al quale racconta la storia e padroneggia il tempo, dilatandolo o restringendolo secondo le esigenze della narrazione. Neologismi e combinazioni nuove, escono naturali dal corpo del racconto, frutti della sua plastica immensa corposità.
Così inizia il romanzo:
Il sole tramontò quattro volte sul suo viaggio e alla fine del quarto giorno, che era il quattro di ottobre del millenovecentoquarantatre, il marinaio, nocchiero semplice della fu regia Marina ‘Ndrja Cambrìa arrivò al paese delle Femmine, sui mari dello scill’e cariddi.
Imbruniva a vista d’occhio e un filo di ventilazione alitava dal mare in rema sul basso promontorio. Per tutto quel giorno il mare si era allisciato ancora alla grande calmerìa di scirocco che durava, senza mutamento alcuno, sino dalla partenza da Napoli: levante, ponente e levante, ieri, oggi, domani e quello sventolio flacco flacco dell’onda grigia, d’argento o di ferro, ripetuta a perdita d’occhio.
Tra i personaggi del libro che non si dimenticano è Ciccina Circé, la traghettatrice dal volto ovale e scuro, attorno al quale le trecce a serpentina “pendevano, lunghissime, sino alle caviglie e rilucenti d’un forte splendore nero corvino.” Ciccina Circé trasporta di notte l’eroe dalla costa calabra a quella siciliana, facendo scivolare la sua barca linda linda sulle acque dello scill’e cariddi, e il mormorio della sua voce morbida e sciacquosa e invitante è quello delle onde su cui il suo respiro si sforza e si spezza e riprende mentre rema, è quello della femmina eterna che freme e spasima per il suo maschio eterno:
“Cavalcatemi, cavaliere” gli resospirava intanto all’orecchio. “Fate, fatemi vedere se veramente fu merito, fu valentìa, restarvene salvo e sano. Non lo pigliate per capriccio, non mi fate offesa, non mi ridete sopra. Mi scordai di quant’è che non assaggio uomo. Fate conto che sotto le fuliggini ritornai verginella. E voi usatemi delicatezza, usatemi forza di persuasione, come si usa a una verginella. Ma cavalcatemi, cavaliere, cavalcatemi. Cavalcatela senza risparmio la cavalcatura, speronatela, cavaliere. E fate, fatemi, fatemi sangue quanto ne volete, feritemi, feritemi, fatemi fare ahi, fatemi sentire ancora viva, in mezzo a questo mare di morti. Abbiate bontà, giovinone bello: pietà……”
Nel passaggio dall’una all’altra sponda ‘Ndrja di nuovo conosce l’incontro e lo scontro dei sessi, il momento senza parole nel quale i ricordi e i desideri e le domande divengono danza dei corpi e le tensioni sono sospese. Ritornerà Ciccina Circé verso la fine del romanzo, nuda forma danzante su un tavolo per mostrarsi ai soldati inglesi delle forze d’occupazione, nuova versione del mistero insondabile della femmina. ‘Ndrja Cambrìa non riuscirà ad insultarla.
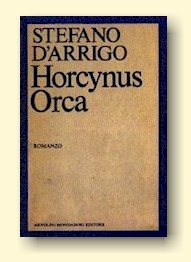
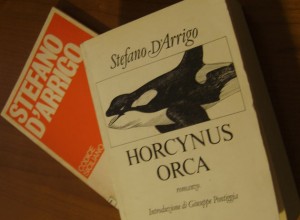
Sopra tutte le figure, vasta come il romanzo, è l’Orca, che si smuove “dal sonno di roccia, avvolta in nebbie fitte, in nuvolosità nere fumose”; l’animale immenso che brancola nel fondo del mare “ancora cieco e sonnoso, oscuro e inavvertito come tutti i cataclismi nelle loro sotterranee origini, quando non se ne ha ancora segno e sono già sotto i nostri piedi.” Nella sua lenta emersione dalla profondità delle acque l’Orca incarna l’accadere delle vicende grandi e misteriose che l’uomo non può controllare ne spiegare. Questo accadere terribile e sublime è da sempre materia di canto e di narrazione, perché la parola allevia il dolore, nobilita la sfida, eterna l’uomo che sempre si accinge ad affrontarla, pur sapendo che essa sempre sarà troppo forte perché egli ritorni vincitore: “Era l’Orca, quella che dà morte, mentre lei, passa per immortale: la Morte marina, sarebbe a dire la Morte, in una parola.”

L’autore, pensoso
